In Italia, ancora oggi, il tema della parità di genere nella sanità resta un nodo irrisolto. Nonostante le donne rappresentino la maggioranza della forza lavoro medica e sanitaria, infatti, la loro presenza diminuisce man mano che si sale nella gerarchia professionale.
Nel nostro Paese, la presenza delle donne tra i medici al di sotto dei 50 anni è incoraggiante e rimane considerevole anche rispetto all’intero personale del Sistema Sanitario Nazionale. Tuttavia, guardando ai vertici, risulta sottorappresentata.
Come vedremo, questo divario riflette un problema strutturale che stride con il contributo storico delle donne nel campo. Infatti, sono diverse le figure femminili italiane che hanno cambiato la storia della medicina.
4 pioniere italiane che hanno cambiato la storia della medicina
Le limitazioni storiche nell’accesso a istruzione, tecnologia e ruoli di leadership non hanno impedito a diverse donne italiane di trasformare profondamente la medicina e la ricerca scientifica nel nostro Paese. Conosciamole meglio.
Maria Nanni Dalle Donne (1778–1842)
Fu tra le prime donne italiane a indossare il camice da medico in un’epoca in cui la scienza era declinata quasi esclusivamente al maschile. Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1799, entrò a far parte dell’Accademia delle Scienze di Bologna, muovendosi un po’ sulle orme di Laura Bassi (prima donna a ottenere un incarico ufficiale di docenza universitaria).
Nel 1804, le fu affidata la direzione della nuova scuola per levatrici: vì formò allieve provenienti non solo da Bologna ma anche da altre province, alternando lezioni teoriche e pratica sul campo. Per quasi 40 anni, nonostante le difficoltà dell’epoca, continuò a insegnare e a guidare la scuola, diffondendo una cultura medica attenta non solo al parto, ma anche all’igiene, alla prevenzione e alla cura del neonato.
Giuseppina Cattani (1859–1914)
Una delle prime donne a entrare nel campo della microbiologia in Italia, fu allieva di grandi maestri (come Guido Tizzoni e Corrado Tommasi-Crudeli) e si distinse per rigore e passione scientifica.
Nel 1889, in collaborazione con Tizzoni, isolò il bacillo del tetano, aprendo la strada al siero antitetanico che avrebbe salvato migliaia di vite. In aggiunta, firmò decine di articoli scientifici, svolgendo un ruolo nella ricerca sulle malattie infettive in un’epoca in cui le donne erano spesso tenute ai margini delle accademie.
Giuseppina Cattani fu anche la prima donna ammessa alla Società medico-chirurgica di Bologna e docente in Patologia generale, ma ciò non le impedì di impegnarsi attivamente per l’emancipazione femminile.
Maria Montessori (1870–1952)
Prima donna a laurearsi in Medicina all’Università di Roma, iniziò la sua carriera tra ostacoli e diffidenze tipiche di un’epoca in cui la professione era appannaggio quasi esclusivo degli uomini.
Specializzatasi in psichiatria e neurologia infantile, lavorò inizialmente con bambini con difficoltà cognitive e successivamente sviluppò il metodo Montessori, fondato sull’osservazione scientifica dei bambini e sulla convinzione che l’educazione dovesse promuovere autonomia, sviluppo individuale e benessere sociale.
Rita Levi-Montalcini (1909–2012)
Dopo aver conseguito la laurea in Medicina nel 1936, intraprese la specializzazione in neurologia e psichiatria. Fu costretta a continuare le proprie ricerche in un laboratorio improvvisato a causa dell’entrata in vigore delle leggi razziali fasciste, ma in quelle condizioni riuscì a condurre gli studi che portarono all’individuazione del Nerve Growth Factor (NGF), una proteina essenziale per la crescita e la sopravvivenza delle cellule nervose.
Il valore di questa scoperta le aprì le porte dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti nel 1968 e, quasi vent’anni più tardi, le valse il Premio Nobel per la Medicina (1986), riconoscimento che la consacra ancora come l’unica donna italiana insignita di tale onore.
Docente presso l’Università di Washington e fondatrice del Laboratorio di Biologia Cellulare del CNR di Roma, Rita Levi-Montalcini unì un forte impegno civile e sociale alla carriera scientifica. Nel 2001, fu nominata senatrice a vita, influenzando in modo in modo significativo le decisioni legislative, in particolare quelle legate alla scienza.
Le donne italiane oggi in medicina
Nonostante esempi al femminile così importanti, la strada per la parità in Italia sembra essere in salita. Oltre il 60% degli studenti di medicina è costituito da donne e le donne rappresentano circa il 50% dei medici under 70, ma solo una minoranza arriva a ruoli di vertice:
- fino al 2020, il 25% dei direttori delle strutture ospedaliere semplici era donna mentre la percentuale scendeva al 19% nelle strutture complesse;
- le donne rappresentano il 36,1% dei direttori sanitari e il 42,1% dei direttori amministrativi;
- nelle università di medicina, almeno fino al 2020, le donne a ricoprire la carica di professore ordinario erano il 19,3 %, le associate il 33 %, mentre le ricercatrici tra il 40 e il 55 %.
Il gender gap si riflette anche sotto il profilo economico: il reddito medio delle donne medico è inferiore di circa il 33-35% rispetto a quello degli uomini. Più in particolare, il reddito annuo si aggira intorno ai 56.500 euro per gli uomini e ai 38.000 euro per le donne. La forbice resta evidente in tutte le fasce d’età: ad esempio, tra i 30-39 anni i medici uomini guadagnano in media 46.000 euro contro i 32.000 delle colleghe e tra i 40-49 anni dichiarano 70.000 euro contro 45.000 euro.
Perché ricordare le pioniere italiane è importante oggi?
Le donne che hanno segnato la storia della medicina non sono solo esempi di eccellenza scientifica, ma modelli di riferimento ai quali guardare per superare le barriere invisibili che ancora frenano carriere e ruoli di leadership.
Per colmare il divario attuale occorre intervenire sui fattori ostativi, rafforzando l’azione a livello culturale e politico attraverso:
- Quadro normativo e istituzionale a sostegno della parità di genere;
- Programmi di mentorship, sponsorizzazione e modelli positivi;
- Politiche di flessibilità lavorativa che portino a una migliore conciliazione vita familiare-lavoro;
- Trasparenza dei dati e degli obiettivi per monitorare i progressi e guidare le decisioni.
L’attuazione di queste azioni rappresenta un passo necessario per ridurre le disuguaglianze e favorire l’accesso delle donne a posizioni dirigenziali nel segno di coloro che le hanno precedute.

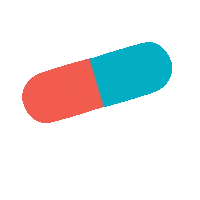

Lascia il tuo commento