Il telefono squilla per pochi secondi, una voce gentile e un po’ emozionata mi accoglie dall’altra parte della cornetta. È la voce di Laura, professione infermiera, che ha accettato di raccontarmi la sua storia durante questa emergenza.
Le spiego brevemente la mia idea e gli argomenti che vorrei approfondire. Pian piano le nostre voci si abituano l’una all’altra, il racconto di Laura comincia e io mi sento come travolta da un fiume in piena.
Perché la realtà che vivono quelli che noi oggi chiamiamo, giustamente, eroi e che affrontano in prima linea questa terribile pandemia, è una realtà dura e piena di difficoltà, che porta con sé tante emozioni, ma che talvolta, non li fa sentire degli eroi.
Tor Vergata

Laura al Tor Vergata durante il servizio
La vita in ospedale è iniziata a cambiare alla fine di febbraio. Dopo anni di lavoro ambulatoriale e giornaliero Laura si è ritrovata ad affrontare nuovamente il lavoro di turnista, prima nel reparto di terapia intensiva e poi in sub-Covid.
Erano vent’anni che non entrava in terapia intensiva.
L’impatto iniziale è stato accompagnato da un senso di smarrimento che purtroppo non poteva permettersi: la situazione stava precipitando velocemente, non c’era tempo per indugiare.
Nuovi turni, nuovi colleghi, nuove uniformi dovevano diventare la sua routine.
Così si è buttata, riuscendo ad acquisire in tempi record procedure e manovre doppiamente complicate a causa della pandemia, per un reparto che già a cose normali è altamente specializzato.
Nonostante la voglia di mettersi in gioco per poter gestire al meglio la situazione, nonostante l’aiuto e il supporto dei colleghi più esperti, il senso di inadeguatezza non l’ha mai abbandonata.
Perché lavorare e fare del proprio meglio in situazioni come questa sembra non bastare mai. Gli sforzi possono sembrare sempre vani e così, il senso di frustrazione nato da questo timore di non riuscire è cresciuto dentro di lei giorno dopo giorno.
E poi ci sono le notti, notti insonni a cui abituarsi, notti di corsa per cercare di tamponare le emergenze, notti di urla a causa delle protezioni che impediscono una comunicazione naturale con i colleghi.
Ma di naturale ormai in ospedale c’è rimasto ben poco e Laura lo sente. Sente la tensione, una tensione che non aveva mai provato prima, in quel lavoro che ha scelto per passione e che ha sempre svolto con una tranquillità, che sa, che non sarà facile ritrovare.
D’altronde, la pandemia, si è persino portata via il nome del suo Tor Vergata, oggi Covid Hospital 4 di Roma.
Casa

Laura in famiglia
Anche a casa le cose non sono proprio le stesse. Laura parte ogni giorno con un carico emotivo importante e un mantra sempre impresso nella mente “devo stare attenta a non essere contagiata, altrimenti lo riporto a casa”. E lì ad attenderla ci sono il marito Fabio e i suoi due figli, con i quali ormai da mesi non ci sono più baci né abbracci, ma una distanza fisica di almeno un metro, un metro e mezzo.
Così, rientrare a casa al tempo del Covid significa essere presente in una nuova quotidianità, fatta di tg guardati tutti insieme e di domande a cui dare risposte mirate, per cercare di colmare dubbi, ma soprattutto per non nascondere niente di ciò che accade.
Laura però si sente anche fortunata, perché i suoi figli sono abbastanza grandi per comprendere la situazione, mentre molti dei suoi colleghi che hanno figli più piccoli stanno vivendo un vero e proprio dramma. Racconta di crisi, di pianti ininterrotti, di genitori disperati che non riescono a mantenere le distanze dai figli, di allontanamenti forzati per proteggere bambini, troppo piccoli per comprendere la pandemia, ma soprattutto troppo piccoli per comprendere il distaccamento dai genitori.
Laura a volte cerca di immedesimarsi in queste situazioni e, quando lo fa, si rende conto che tutto questo non si fermerà con la fine dei contagi, ma avrà forti ripercussioni anche nel “dopo”.
Il tempo sospeso
In ambulatorio, il rapporto che Laura aveva con i pazienti era un rapporto circoscritto, limitato al tempo dell’esame. Non c’era tempo di conoscere, non c’era tempo di affezionarsi, una volta finita la procedura tornavano semplicemente a casa.
Anche questo aspetto è cambiato con l’arrivo del Covid: in terapia intensiva il rapporto era a senso unico, perché i pazienti erano sedati e intubati, ma il fatto che fossero completamente soli in una situazione così delicata, l’ha sempre spinta a parlarci, per cercare di essere almeno un po’ di conforto.
Durante il mese passato lì, infatti, nessuno dei suoi pazienti è riuscito a tornare a casa, facendo crescere in lei un senso di impotenza difficile da sopportare.
Racconta che in quel periodo passava le notti a cercare di “tenerli in equilibrio” per ritardare l’inevitabile, così da non dover svegliare i familiari durante la notte.
Perché in quei familiari Laura ci si era immedesimata in una maniera diversa rispetto al solito, una maniera che l’ha portata a dire a sua madre “meno male che al babbo è successo prima, almeno abbiamo potuto salutarlo”.
Per lei, infatti, il paziente che non esce dall’ospedale porta con sé un qualcosa di interrotto, come fosse un ponte spezzato. Perché quelli che se ne vanno durante questa pandemia è come se non ci fossero mai stati.
Una sensazione atroce, che dà tanta tristezza, una tristezza che la morte dà sempre, ma che, se vissuta così, appare ancora di più drammatica, perché priva di commiato.
Adesso Laura si trova nel reparto chiamato sub-Covid, nel quale sono ricoverati i pazienti sospetti. Anche qui il dramma della solitudine colpisce e disorienta, specialmente i più anziani.
A volte riesce ad aiutare qualcuno a chiamare i nipoti con il cellulare, ma si rende conto che spesso sono conversazioni a senso unico, perché l’isolamento fa perdere ai pazienti il senso del tempo e dello spazio.
E poi c’è la questione delle protezioni. Il non farsi vedere in faccia non permette né a Laura né ai suoi colleghi di poter essere il conforto che vorrebbero e la sensazione è quella di non riuscire ad infondere abbastanza fiducia nei pazienti che stanno cercando di aiutare.
Anche qui dunque, la relazione è una relazione a metà e da entrambe le parti il senso di disorientamento è forte e lo si percepisce.
Di tutta questa tragedia, Laura sa che non dimenticherà mai quella sensazione “di essere sporca”, le docce infinite per togliere quell’odore, quel sentore di ospedale che non sembra voler uscire dalle narici; quel senso di incertezza che ti porta a vivere in un limbo, perché nessuno sa quando tutto questo finirà.
La malinconia, perché la vita di prima manca, quella vita “normale” fatta di affetti, di libertà che prima davamo tutti un po’ più per scontata e che adesso manca soprattutto nelle piccole cose, nei piccoli gesti.
Ma tutto questo fa parte della sua nuova routine, una routine alla quale, purtroppo si è già abituata, ma alla quale non vuol cedere del tutto.
Perché nelle sue parole, nonostante tutto, c’è anche speranza, la speranza di chi non vuole arrendersi alla disperazione di una situazione così drammatica, la speranza di chi continua a lottare con la convinzione che questa battaglia, alla fine, la vinceremo noi.

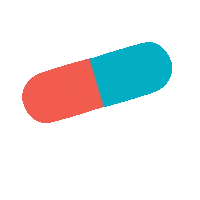

Lascia il tuo commento